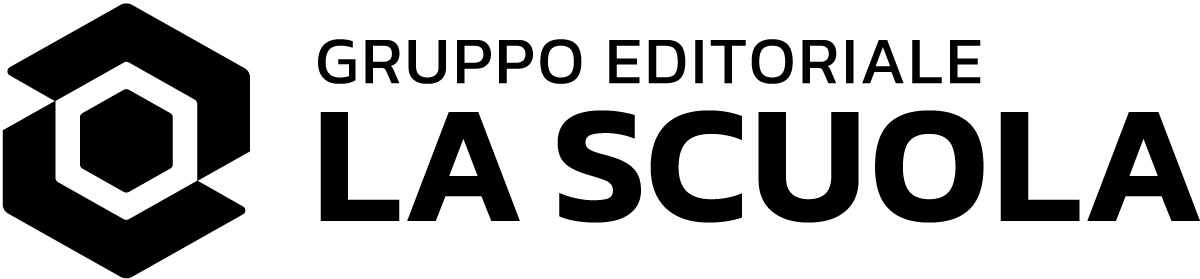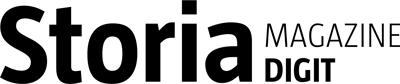Il diritto di famiglia in Grecia
Circa il mondo greco, la nostra attenzione si concentra principalmente su Atene, la sola polis di cui conosciamo con un certo approfondimento il sistema giuridico. Il termine che indicava la famiglia era oikos: parola che in realtà significa anche “casa”. E infatti l’oikos non era solamente la famiglia in senso stretto, ma includeva anche il patrimonio e perfino gli schiavi. A capo vi era il padre, che era chiamato kyrios (cioè “signore” o “padrone”), e aveva una posizione di preminenza sulla moglie e sui figli, finché questi erano minorenni.
Il matrimonio era il cardine della famiglia, in quanto permetteva di distinguere i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) da quelli illegittimi o naturali: solo i primi, se maschi, diventavano eredi del padre alla sua morte. Il matrimonio non sorgeva con un atto giuridico iniziale, ma si basava sulla coabitazione tra i coniugi e pertanto poteva confondersi con il semplice concubinato. Le fonti antiche indicano che per tale motivo nel 594 a.C. il legislatore Solone dispose che il matrimonio doveva essere preceduto da un fidanzamento formale, nel corso del quale il padre della donna la prometteva in sposa al futuro marito e le assegnava una dote. Il matrimonio poteva cessare con il ripudio della moglie da parte del marito oppure con l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, fatti che configuravano il divorzio.
Ad Atene, la moglie aveva l’obbligo di fedeltà coniugale: non le era consentito avere rapporti sessuali con uomini diversi dal marito, perché la famiglia era ritenuta un gruppo chiuso nel quale non doveva entrare sangue estraneo. Se la moglie commetteva adulterio, il marito che ne venisse a conoscenza aveva l’obbligo di ripudiarla, altrimenti subiva una sanzione, l’atimia, per cui perdeva i diritti politici. Aveva inoltre il diritto di ucciderne l’amante se colto in flagrante.
[…] Invece a Sparta, come viene riportato da Plutarco, con il consenso del marito le donne potevano anche intrattenere rapporti sessuali extramatrimoniali: lo Stato semplicemente auspicava che anche in tal caso le donne generassero figli sani che potessero diventare ottimi soldati. Tanto a Sparta, quanto ad Atene gli uomini sposati potevano lecitamente mantenere una concubina.
Per quanto concerne la filiazione, il padre decideva se un nuovo nato da sua moglie dovesse essere accolto o meno nella famiglia.
Qualora un uomo sposato generasse figli con una concubina di cittadinanza ateniese, poteva anche legittimarli, includendoli nell’oikos come propri figli legittimi, benché fossero in realtà adulterini. Il cittadino ateniese poteva inoltre adottare dei figli, se non ne aveva di propri.
Per altro verso, con un atto che si chiamava apokeryxís il padre poteva escludere dall’oikos i figli, anche adulti, che si fossero macchiati di colpe gravi o che avessero disonorato la famiglia.
Il punto centrale del diritto di famiglia ateniese, che lo differenzia profondamente dal diritto romano, è che con il raggiungimento della maggiore età, al compimento del diciottesimo anno, i figli maschi cessavano di essere giuridicamente soggetti al padre: da quel momento, essi condividevano con lui il governo dell’oikos. Alla morte del padre, i figli maschi ne sarebbero stati gli eredi e avrebbero garantito la continuità della famiglia.