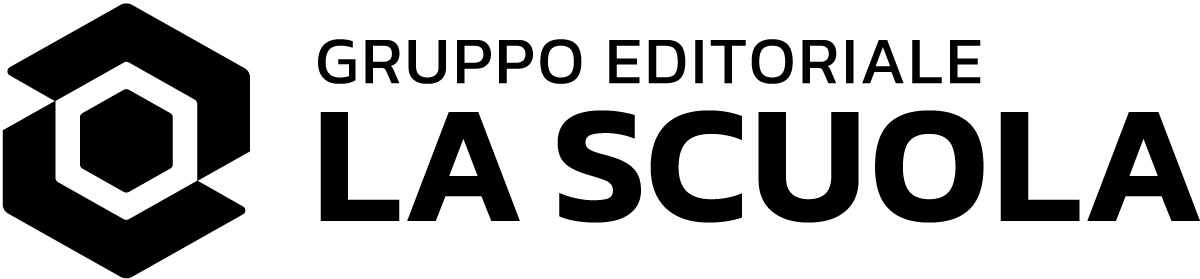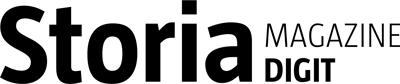La sequenza: Lutero a Worms
Una delle tappe fondamentali verso l’affermazione della Riforma fu la Dieta di Worms del 1521, l’assemblea dei prìncipi tedeschi nella quale Martin Lutero poté parlare davanti all’imperatore con la certezza di non essere arrestato. Correttamente il film divide l’audizione di Lutero in due giornate diverse. Fu proprio il monaco, dopo il primo incontro con le autorità, a chiedere un giorno in più per pensare a una risposta adeguata. Nella sequenza vediamo la seconda delle due giornate: 17 aprile 1521.
Non possiamo parlare di un capolavoro del cinema, ma di un’opera certamente interessante e soprattutto utile per ripercorrere alcuni eventi importantissimi della storia.
Dalla parte della Riforma
Pur usando uno stile semplice, senza complicati accorgimenti per forzare il giudizio del pubblico, il film mostra evidenti simpatie verso Lutero e la Riforma. Nella sequenza del viaggio a Roma, dove il monaco ha modo di vedere con i suoi occhi la corruzione della Chiesa dell’epoca, il punto di vista è quello del futuro riformatore, le cui ragioni sono presentate come «giuste», mentre le istituzioni ecclesiastiche sono dalla parte del torto. Questa impostazione prosegue nel resto del film, presentando la vicenda come una lotta di Lutero per ristabilire la verità e la giustizia negate dai suoi avversari, senza fare alcun riferimento agli impulsi riformatori interni alla Chiesa cattolica. I personaggi, raffigurati in modo elementare, chiarendone sempre pensiero e obiettivi, sono suddivisi in «buoni» e «cattivi».
Lutero e gli altri
Qualche ulteriore esempio può aiutare a comprendere l’orientamento del film e i modi con cui si manifesta. Mentre Lutero agisce sempre seguendo la propria coscienza e alla luce del sole, i suoi oppositori sono spesso in mala fede e tramano nell’ombra, cercando di ottenere con il sopruso gli obiettivi che non riescono a raggiungere con un confronto aperto e leale; in generale, le motivazioni di Lutero e dei suoi seguaci sono di ordine ideale, morale, oltre che religioso, mentre quelle degli avversari riguardano l’utile: da una parte l’etica e i princìpi, dall’altra la politica e il calcolo. È evidente invece che il successo della Riforma fu dovuto a un insieme di fattori, e che il calcolo politico ebbe un ruolo decisivo in entrambi gli schieramenti. Su un piano più esteriore, Lutero e i suoi seguaci – compreso il principe elettore Federico il Saggio – appaiono uomini generosi, gentili e alla buona; al contrario Johann Tetzel e papa Leone X sono figure poco gradevoli nell’aspetto e comunque arroganti, come il nunzio papale Girolamo Aleandro. Persino chi prende le parole di Lutero troppo «alla lettera» acquista una luce negativa: è il caso di Andrea Carlostadio, personaggio dapprima positivo che tuttavia esce di scena come rivoltoso esaltato.

Attendibilità complessiva
Nonostante la parzialità del punto di vista, non si può dire che Luther - Genio, ribelle, liberatore sia un film ingannevole. Lo scenario storico che presenta è sostanzialmente attendibile, incluse le pesanti critiche al clero di quel periodo. Inoltre, il film non nasconde alcuni tratti oscuri e problematici della personalità di Lutero. In particolare, le crisi spirituali della giovinezza e l’incoscienza con cui si getta nelle battaglie più pericolose, incurante delle conseguenze, possono far pensare a un uomo vicino alla pazzia, sebbene anche questi aspetti vadano a rafforzare l’immagine di Lutero come individuo permeato di sentimento religioso e animato da una totale buona fede.